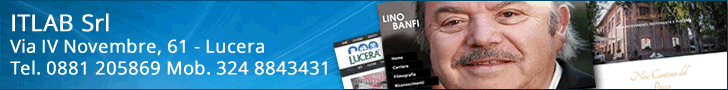Il quadro scelto per questo terzo mese dedicato alla nostra affezionata rubrica, è una bellissima tela che si trova nella Basilica di San Francesco d’Assisi, precisamente nella Cappella dell’Arciconfraternita della Santa Croce – SS. Trinità e della B.V. Maria Addolorata, L’esaltazione della Santa Croce.
Il dipinto, tornato all’antico splendore grazie al recente restauro (2016/2017) effettuato da Francesca Inglese, si distingue per le sue dimensioni monumentali che accreditano l’idea di un iniziale uso come pala d’altare, e successivamente riadattato e collocato in una seconda sede, come testimonia la decurtazione nella parte superiore. La raffigurazione si focalizza sull’esaltazione della Croce che occupa la posizione centrale di tutta la superficie; tuttavia, suscita stupore e sbigottimento la mancanza del corpo di Cristo, il cui sangue bagna il legno sacro. Un’assenza che diventa presenza, quando si arriva a giustificare la concitazione della moltitudine di personaggi che affollano la scena; tra questi si riconoscono soldati armati e vestiti con abbigliamento cinquecentesco, tipico elemento anacronistico che si somma alla partecipazione di alcuni turchi che potrebbe rimandare alla battaglia di Lepanto tra le truppe veneziane e quelle turche nel 1571 (termine post quem). In basso a destra, quasi a spezzare la tensione del momento, fanno capolino gli incappucciati, che stanno a rappresentare i committenti dell’opera, ovvero gli appartenenti dell’Arciconfraternita della Santa Croce. Infine, la parte più significativa e ricca di pathos è sicuramente la zona sottostante la croce con le pie donne, tra cui spicca la Maddalena, riconoscibile per i suoi lunghissimi capelli dorati, impegnate a sorreggere l’Addolorata che, con gli occhi chiusi e il pallore in viso, si abbandona al dolore, dopo aver dato l’estremo saluto al Figlio.
Fino ad oggi, si brancolava nel buio circa l’identità dell’autore che risulta, tuttora, ignoto. Sono state fatte varie ipotesi e congetture nel corso degli anni circa questa questio; dopo ricerche, siamo pronti a condividere, per la prima volta, la nostra interpretazione e a suggerire un nome, anzi due.

Per l’individuazione siamo partiti dalla scritta posta in basso a sinistra del quadro, più precisamente sullo scudo, che non costituisce né una data, né il nominativo dei committenti, come ipotizzato, ma la sigla degli autori dell’opera. La sigla è la seguente: IBGB. A nostro avviso, questo è un acronimo che sta a indicare i nomi di Iacopone Bertucci e di suo nipote Giovanni Bertucci che lavorarono insieme durante il periodo della presunta datazione (fine del XVI sec).
Jacopo Bertucci, noto anche come Iacopone o Giacomo Bertucci, nato a Faenza nel 1502 e morto a Faenza nel 1579, è stato un pittore e scultore italiano, figlio minore di Giovanni Battista Bertucci il Vecchio, anch’egli pittore. Non si hanno notizie sulla sua formazione giovanile, forse avvenuta presso la bottega del padre, e probabilmente frequentò l’Accademia di San Luca. È stato operativo nella sua Faenza, a Ferrara e dintorni, ma anche a Roma. La sua produzione artistica è concentrata in quella zona; tuttavia, alcuni esemplari sono conservati anche al Louvre.
La pala che ci ha ricondotto a lui è quella del Cristo deposto dalla croce, situato nel museo di Faenza, finito tra il 1552 e 1553 e commissionato anch’esso da una Confraternita, quella di San Rocco, che potrebbe avere avuto contatti anche con la Confraternita di Lucera e avere una raccomandazione dal vescovo del periodo, Pietro de Petris (1553 – 1580) di Monte San Savino.
Come la nostra pala, è anch’essa di notevoli dimensioni (cm 380 x 235), ma non è l’unica similitudine che abbiamo riscontrato. In uno scenario collinare si erge la croce, vista secondo un’angolazione di tre quarti, ai cui piedi ha luogo la deposizione di Cristo, appena calato dalla croce e posto su un drappo bianco da due portatori. Tutt’intorno si sovrappongono varie figure, animate da sentimenti contrastanti: in secondo piano vi sono soldati, curiosi, gitanti a cavallo, gente che chiacchiera incurante dell’evento drammatico, ad accentuare il contrasto con il nucleo principale. Oltre al tema ricorrente e alla simile impostazione (la netta distinzione di due livelli narrativi), vogliamo porre l’attenzione sulle affinità tra le due Madonne, che si rispecchiano nei colori degli abiti e nella posa scomposta; ci sono, inoltre, delle congruenze tra i visi dei soldati (vd. infra anziano con la barba) e i loro elmetti, così come per i copricapi delle pie donne.
(Particolari dei due quadri a confronto: a sinistra “la Deposizione” di Lucera e a destra il “Cristo deposto dalla croce” di Faenza). Clicca sulle immagini per ingrandirle.
(Le foto qui riportate sono state scattate dagli scriventi, è vietata la riproduzione dei testi e delle immagini senza il consenso scritto dei legittimi autori)
Annarita e Gianni Mentana